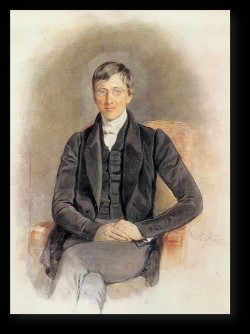 Anticipiamo alcuni stralci di un articolo che sarà pubblicato sul prossimo numero del bimestrale “Vita e Pensiero”.
Anticipiamo alcuni stralci di un articolo che sarà pubblicato sul prossimo numero del bimestrale “Vita e Pensiero”.
di JULIA KRISTEVA
Nell’Apologia pro vita sua (1864) John Henry Newman ricorda il “grande cambiamento” che “si produsse nei suoi pensieri” all’età di quindici anni. Da allora, più che un’impronta o un’impressione, il dogma cristiano divenne per lui una “certezza assoluta”: “Ancora oggi (quarantanove anni dopo) ne sono più sicuro che di avere piedi e mani”. Intensa concentrazione, isolamento totale dalla “realtà dei fenomeni materiali” e null’altro che “due esseri” “la cui evidenza” è tanto “luminosa” quanto “assoluta”: Myself and my Creator. La scena è ambientata nel 1816. La banca del padre fallisce, l’anno successivo il quindicenne non può raggiungere la famiglia per le vacanze estive e rimane in collegio a Ealing: separato dai suoi, ma circondato dall’attenta comprensione del reverendo Walter Mayers, protestante evangelico.
L’adolescente prova dunque la realtà assoluta (la “certezza”) di quella che chiamerò la co-presenza tra l’Io e il suo Creatore. Si tratta di una “sensazione”? Il termine è troppo soggettivo, “derisorio” dice Newman, a mocquery, nei confronti dell’inevitabile “impronta” imposta all’Io da una realtà fuori-dell’Io. Si tratta forse di una realtà impersonale? Le parole sono a tal punto impotenti a dar nome all’iscrizione di tale evidenza assoluta, che il teologo ricorrerà ai paragoni e alle metafore: ispirate prima al corpo (“più sicuro che di avere piedi e mani”) e infine al fatto del padre antropologico. Come l’amore filiale non esiste senza il fatto del padre umano, la pietà non esiste se l’Essere assoluto non è un fact.
Newman preferisce dettagliare logicamente una serie di atti cognitivi che chiama atti di coscienza e che costellano il processo eterogeneo del credere: “Ombre e immagini verso la verità” (sarà il motto inciso sul suo memoriale a Edgbaston) e una certezza razionale che ne scaturisce infine: “So che so che lo so…”. L’affermazione termina con i puntini di sospensione, come per evocare un processo di sapere infinito (come il pi greco di Leibniz).
Dall’intuizione anteriore alla razionalità fino alla razionalità enunciata dal Credo: Newman conserva la luminosità segreta (“soprannaturale”, dice) della sua fede, che descriverà anche come un inward sense (senso interiore), o ancora come cor (il cuore di sant’Agostino): Cor ad cor loquitur (sarà il suo motto di cardinale). Il termine “affetto”, che san Bernardo di Chiaravalle aveva ripreso dalla Scolastica per farne un concetto chiave della sua lettura del Cantico dei Cantici, non sembra venire alla penna di Newman. Però s’impone, se si vuole afferrare quella zona ampia e fragile che Newman chiama la “coscienza” dell’esperienza, o (più tardi) “assenso alle immagini e alle cose” (da distinguere dall'”assenso ai concetti”). Una coscienza che non ha ancora il rigore di un atto cognitivo razionale, ma che evoca la “sfera pre-predicativa” della fenomenologia husserliana, o il senso semiotico (anteriore e sottostante alla sintassi che garantisce il significato simbolico) nella mia concezione della soggettività come un processo di “significato”.
L’eterogeneità di questi atti psichici, costituendo il legame chiamato Credo tra me e il Creatore, richiama subito regimi di parola che non riducono “le ombre e le immagini” ai saperi dell'”io so” concettuale. La nostra cultura li definisce estetici: le arti, la musica, la pittura e, per Newman, la poesia, in presa diretta su quei “germi” di pensiero suggeriti dalle metafore delle “ombre” e delle “immagini”.
A partire da quella certezza dell’unione tra l’Io e il Padre/Creatore, il Credo secondo Newman cesserà di essere un’impronta, per svilupparsi come un legame intersoggettivo e amoroso. Sarà proprio questa rivelazione amorosa a condurlo dai padri bizantini e dal protestantesimo alla Chiesa cattolica. Seguiamo il movimento in tre tempi della soggettivazione amorosa.
La concezione della fede come impronta (éikon) del Creatore nel credente, della sua icona e della sua economia è stata sviluppata nel IX secolo, in particolare dal patriarca Niceforo, nel corso del dibattito bizantino sull’autorizzazione delle raffigurazioni di Dio. Insistendo sulla deposizione/ricezione/iscrizione del patto con il Creatore, quell’economia rischiava di introvertire il credente in ciò che Newman chiama unworldnesness: ritiro dal mondo, addirittura fonte di “disperazione” nel cristianesimo evangelico.
Al contrario, grazie all’analogia subito stabilita da Newman tra il Creatore e il fatto della paternità umana vivente, per lui il Credo si chiarisce in tutt’altro modo. L’impronta diventa una grazia che non è solo attribuita per analogia, ma è impiantata da e per l’amore del Padre. Ben più che una ricezione o un’applicazione della Legge biblica. E non più solo una partecipazione al Bene generale dell’Essere Bene (il Bonum neutro, alla maniera filosofica o tomista). La fede sarà la “certezza” di una co-presenza con il Bonum singolare (dirà Maurice Blondel). Intendiamo: una personalizzazione duale del legame. Io attraverso Lui perché Lui per Me. È un’iniziativa del credente, nel senso che lui non si accontenta di imitare, ma partecipa. Il dono amoroso sarà inteso come gratificazione e al tempo stesso come prova: un conflitto permanente, nello scollamento tra chiamata e risposta. E tuttavia un’identificazione totale riunisce il Figlio con il Padre in un solo Spirito.
Newman non esplicita il carattere affettivo di questo movimento: si limita a tracciare la dinamica eterogenea e l’unità logica del processo. Tuttavia il suo modo d’intendere la co-presenza Io/Creatore fa del credente il Tempio dello Spirito. Abolisce la separazione tra il giusto e l’eletto e prende in considerazione un nuovo regime della soggettività nella fede: quello del rinnovamento (“la crescita è l’unica prova della vita”, Newman ama citare Thomas Scott), implicando che la verità della Fede non è incantesimo, ma libertà come conquista e dramma: perché “il nostro cuore è senza riposo”.
La decisione di credere include i “poveri e gli illetterati”: gli stessi che “sentono” (ancora questa certezza della percezione pre-razionale). L’unificazione dell’Io con il suo Creatore si “realizza” nell’universalità più ampia, quella dell’umanesimo cristiano che associa il genere umano a quel per modum unius vissuto come legame d’amore.
Sarà questo il senso ultimo della santità che si realizza, secondo Newman, laddove esiste la “certezza indefettibile” (Grammatica dell’assenso) della co-presenza tra l’Io e il mio Creatore. “La santità, ecco il grande scopo. Dev’esserci una lotta e una prova” (citato da Trevor, The Pillars and the Cloud, p. 55). Fondandosi sulla certezza sensibile – passando attraverso la coscienza che tale co-presenza è una tensione – e inglobando la certezza che tutti gli uomini partecipano di tale evidenza, lo sappiano o meno.
Benché Newman non abbia rivendicato il termine “mistico”, l’assemblaggio tra assenso e immaginazione, da una parte, e grammatica dell’inferenza-giustificazione, dall’altra, arriva a integrare l’esperienza mistica nel consolidamento di un dogma cattolico che gli sembra dover essere delucidato e protetto. Tale cammino, che porta il protestante Newman al cattolicesimo e che non è sfuggito a un Henri de Lubac, lo conduce a un’altra certezza, che non ha formulato esplicitamente ma che riassumerei così: l’essenza dell’ethos cristiano è mistica.
Alcuni hanno fatto della mistica una chiave per aprire le porte della fede a nuovi mondi: Meister Eckhart prepara il vocabolario della filosofia europea, mentre Teresa d’Avila avvia la transizione barocca al secolo dei Lumi. Newman, da parte sua, protegge il cattolicesimo tanto dal moralismo protestante quanto dal criticismo razionalista e rinsalda i fondamentali del cattolicesimo attraverso una paziente descrizione del legame Padre/Figlio che sta dietro al Verbo, dimostrando che quell’esperienza – che solo surrettiziamente chiama “amorosa” (nella Grammatica dell’assenso, ad esempio) – è il fondamento ultimo del senso etico. Nella mistica riconosce il fermento necessario a rifondare il dogma, rendendolo più complesso e dinamico. Nell’universo indoeuropeo, la parola latina credo risale al sanscrito sraddha che denota un atto di fiducia in un dio, implicando restituzione sotto forma di favore divino concesso al fedele. Da tale radice deriva, laicizzato, il credito finanziario: io deposito un bene aspettandomi una ricompensa.
Il mio bisogno di credere, che mi offre le condizioni ottimali per sviluppare il linguaggio, sarà il fondamento sul quale potrà fondarsi un’altra capacità, corrosiva e liberatrice: il desiderio di sapere. Se e solo se sono portato/a da quest'”investimento”, da questa fede che mi fa sentire un terzo amante/amato a parlargli, solo allora posso finalmente esplodere in domande. Chi non conosce l’ansia giubilatoria del bambino che fa domande? E non smette di riportarci a quell’inconsistenza dei nomi e degli esseri, dell’Essere, che non lo terrorizza più ma lo fa ridere, perché crede che è possibile nominare, far nominare. “So che so che so…”.
A quest’archeologia del “bisogno di credere” dal lato del padre l’ascolto analitico aggiunge oggi i legami precoci madre-figlio, a cominciare da quel “sentimento oceanico” che Romain Rolland aveva indicato a Freud come una componente essenziale del sentimento religioso. Certezza estatica di un corpo senza frontiere e senza organi (le quattro acque di Teresa d’Avila) e minaccia catastrofica di perdita di sé, anzi di dissoluzione biologica (il fuoco di Giovanni della Croce): la clinica esplora quelle esperienze limite quando sfociano nelle “nuove malattie dell’anima” (tossicomania, psicosomatosi, passaggio all’atto suicida, vandalismo ecc.); l’arte moderna vi cerca linguaggi che sfidino la figurabilità e la rappresentazione; e le teorie del significato si riagganciano alle scoperte di Platone nel Timeo, che abbozza uno “spazio prima dello spazio”, un ricettacolo detto chora, che sarebbe nutritivo e materno, anteriore al padre in tutti i sensi, e che tenterebbe un recupero ontologico dell’atomismo di Democrito. Io e la Mia Genitrice/Creatrice: come doppio dell’investimento paterno? La stessa psicoanalisi fatica ancora ad accostarsi a questo continente.
La psicoanalisi non ha lo scopo di trovarci il miglior partner amoroso né la situazione professionale più adatta. La psicoanalisi ci insegna che la capacità di avere senso è ancorata nel destino non solo della funzione paterna, ma in senso più ampio della funzione genitoriale: padre e madre. Infatti siamo in vita se, e solo se, possiamo investire tale funzione, nel senso etimologico di “investire”: unirci affettivamente con la sua alternità amante, per poi interrogarla nel desiderio e attraverso l’innovazione.
Freud, ebreo ateo, l’uomo meno religioso del suo secolo, giunge a questa conclusione stravagante: la mistica e la psicoanalisi mirano a un punto comune. Com’è possibile? L’Io dell’analizzante, liberato dalla tutela del Super-io, amplia le sue percezioni e si consolida in modo da appropriarsi dei frammenti dell’Es. “Là dove Es era, l’Io deve accadere”. Sarebbe questo il lavoro della civiltà: nel lungo periodo, forse impossibile, come il prosciugamento dello Zuidersee. Siamo nel 1932, Freud scrive le sue Nuove conferenze sulla psicoanalisi. Presto calerà la notte sull’Europa e sul mondo.
Ma Freud non abbandona la sua archeologia del “punto di attacco simile” tra psicoanalisi e mistica. Poco prima della morte, il 22 agosto 1938, l’ultimo messaggio della sua mano traccia però una linea di demarcazione in questa similitudine inquietante: “Misticismo: autopercezione oscura del regno, al di là dell’Io, dell’Es”. Intendiamo: immersione e perdita dell’Io nell’autopercezione dell’Es (mistica), ma riorganizzazione dell’Io attraverso un’interminabile delucidazione dell’Es (psicoanalisi). Senza aderire all’esperienza mistica, ma anche senza ignorarla, l’ascolto analitico dà senso al suo godimento: costruendo/decostruendo continuamente il legame edipico, e fino all’Identificazione primaria con il Padre della Preistoria individuale.
È proprio questa capacità di significare, questo significato ancorato nel destino della funzione paterna genitoriale fino agli affetti e le pulsioni, che la psicoanalisi freudiana ci lascia in eredità. Collegando il più profondo intimo alle mutazioni storiche attraverso l’espediente dell’evoluzione delle strutture familiari e della regolazione della riproduzione, il significato onto e filogenetico fa entrare la storia nell’esperienza del lettino. Freud la chiama “un’alta mira negli umani. Lungi dal tradire una qualche regressione idealista, questa teorizzazione designa le logiche di una immanentizzazione della trascendenza, che il fondatore della psicoanalisi ha constatato attraverso e nel transfert, nell’ambito della “cura della parola” che ha inventato.
I Lumi hanno desacralizzato le religioni denunciandone gli abusi, senza peraltro decostruire il bisogno di credere. Lo stesso Diderot, dopo aver immaginato la sua Monaca che, finalmente liberata dalla mortificazione e dagli abusi sessuali, si trova a essere libera attrice nel mondo profano, quel Diderot ateo impenitente, non riusciva a finire il suo romanzo e piangeva. Freud eredita tale ricomposizione, intrapresa da Diderot, della soggettività parlante che pianta in asso l’Ego Cogito e si rivela posseduta dal desiderio amoroso del senso dell’Altro.
Con la teoria dell’inconscio, la modernità cerca di essere più lucida di Diderot. Noi non rinunciamo al bisogno di credere che non ha ancora un “oggetto” in senso proprio, ma si limita a investire di senso una Chora (prima del significato, diceva Platone nel Timeo) o a presentire una Cosa, Res divina (dicevano i dottori): polo calamitato degli affetti, non ancora dissociato da un non ancora “io”. Non rinunciamo, dunque, al bisogno di credere. Ma quando l’oggetto di tale bisogno si fissa in Oggetto Assoluto di desiderio, in Dio Padre consacrato dal credo, gli rivolgiamo i nostri desideri di sapere.
Vi sto forse dicendo che la psicoanalisi è figlia dell’ontoteologia, il suo ultimo avatar, come l’accusano certi detrattori? O è la nostra comune appartenenza alla famiglia patrilineare e patriarcale a farci scoprire le (quasi) identiche logiche nei soggetti scaturiti da questo stesso quadro antropologico, per trarne valori universali? Poiché la “funzione paterna”, e con essa l’equilibrio tra il “bisogno di credere” e il “desiderio di sapere” che sottintende, restano a fondamento della capacità di pensare dell’Homo sapiens, il loro smantellamento o la loro ricostituzione comporteranno cambiamenti del regime di pensare, così come dell’etica sociale. In tale evoluzione la psicoanalisi, ben più che accompagnare accortamente, proteggerà il percorso dal rischio di sbandate.
(©L’Osservatore Romano 2 luglio 2011)
